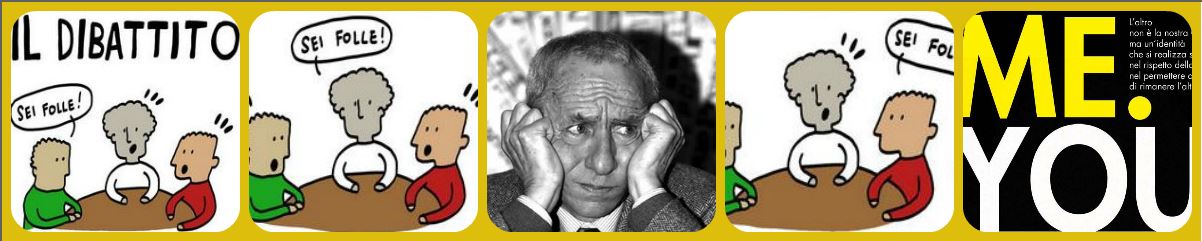
Ripartire non è impossibile
Michele Di Lecce
Alle compagne e compagni dell’Area del Manifesto, sparsi nei Circoli e nelle Fondazioni, nelle Istituzioni, nella Redazione, con spirito unitario, da parte di un “compagno di base”.
Entro subito nel merito delle questioni, spreco solo una riga per dire che prima di decidermi a scrivere ho atteso le conseguenze dell‘esito elettorale: ho sperato di sbagliarmi, ed invece è andata come era previsto. Non ho rimpianti per il mio “voto inutile” a sinistra, se volevamo una conta di quanti siamo, bene l’abbiamo avuta e non è confortante. Le questioni che intendo aprire sono queste.
La prima è: chi siamo? Intendo noi “area del manifesto” (non parlo solo del giornale, in fondo pensato come uno strumento di azione politica, ora divenuto mini trincea da difendere). Parlo dell’area che si è formata via via intorno gruppo espulso dal Pci, attiva politicamente per decenni e con una opzione comunista mai abbandonata, in parte poi rientrata nel partito infine sciolto. La storia la sappiamo e non hanno senso lamentele e ripicche. Però è di noi che intendo parlare, prima che degli altri spezzoni di opposizione.
La seconda è: quali sono stati i nostri errori di fondo? Di fondo: non l’alleanza con questo o quel gruppetto, l’errore (se c’è stato) di accelerare la spinta organizzativa, o i possibili errori ideologici. Questi sono errori che fanno tutti. Parlo dell’incapacità di leggere i processi che si stavano materializzando sotto i nostri occhi, e di non aver avuto forza, armi, ingegno per contrastarli seriamente. Se non facciamo questa operazione dolorosa il linguaggio di confronto diventa incomprensibile. Non possiamo colpevolizzare il gruppo dirigente storico e additarne sopravvalutazioni e sottovalutazioni (come il berlusconismo, il mutamento dei rapporti sociali e fra capitale e lavoro), e - indietro - l’incomprensione di quello che accadeva in Unione Sovietica, di cui la perestroika era la spia, anche se la riflessione va fatta. In fondo anche Lenin sottovalutò i fascismi nascenti, Gramsci finì per perdere, il “partito nuovo” di Togliatti fu espulso dalla direzione del Paese, il gruppo dirigente della Rivoluzione cadde sotto i colpi della nascente dittatura staliniana e così via, fino all’esito cinese. Mai, tuttavia, questi furono motivi di defezione in massa.
La terza è più seria: è possibile una ripartenza o dobbiamo lasciare il campo? Guardiamoci bene in faccia, occhi contro occhi, e guardiamoci intorno senza raccontarci favole: siamo ridotti a coltivare la micro minoranza che compra comunque il giornale perché riporta nel nome la propria radice comunista. Se la conquista è salvarlo, salvarlo così com’è, salvare “la testata”, si dica. C’è una redazione residua che crede oggi (in buona fede) di sostanziare quella radice con qualche “nome importante”, che usa il giornale per prendere posizione, o con l’enfatizzazione di qualche meditazione sociologica, a volte noiosamente ideologica. E, ancora, crede di sostanziarla, quella radice, dichiarandosi sempre e comunque a favore di movimenti sociali nuovi, spesso improvvisi, caduchi, contraddittori e del tutto estranei alla storia del movimento operaio organizzato, senza analizzarne le ragioni, la composizione, gli sbocchi prevedibili.
Quest’ultima opzione appare semplice: “appoggiamo” l’opposizione sociale – ospitandone le opinioni, non abbiamo altro da offrire – e poi si vedrà. Continuiamo insomma a evidenziare le spinte dal basso, a difesa della condizione sociale, della democrazia partecipata, delle conquiste operaie, lagnandosi del neoliberismo, delle guerre locali, della deriva islamista delle opposizioni arabe. Si sottintende, cioè, che la contraddizione non esploderà nei tempi delle nostre vite, però teniamo accesa la candelina dell‘opposizione. Bene, non è così, continuando su questa strada non solo muore il giornale, ma perdiamo tempo, marchiamo la nostra inutilità sostanziale, non abbozziamo neanche un minimo di risposta alla crisi istituzionale, il cui esito è la sterilizzazione della Costituzione, né una risposta ai mutamenti reali nel rapporto di produzione e nella composizione del salario (che richiamano ad una catena di comando e normalizzazione in fabbrica e nel Paese), né una bozza di risposta alla crisi economica reale.
Chiedo allora ai compagni che leggono di fare uno sforzo. Uno sforzo difficile. Lo sforzo di staccarsi per un attimo dalla situazione attuale e allargare lo sguardo. Siamo di fronte alla lavagna e abbiamo scoperto, alla fine di lunghi calcoli, che il risultato non torna, che è privo di senso. Guardare l’ultimo passaggio è inutile, occorre andare più indietro ed analizzare la sequenza. E se non c’è un passaggio errato allora abbiamo sbagliato qualche ipotesi, che va corretta. Prima o poi l’errore si trova. Ecco: cancelliamo gli ultimi passaggi. Calma e gesso, come diceva Magri. Insomma dimentichiamo per un attimo Grillo, Napolitano, Letta, la Tav, i Beni Comuni, la Merkel, Bankitalia, Berlusconi ai domiciliari, ed analizziamo invece i fatti macroscopici, quelli che ci riguardano.
La crisi dei nostri ideali e la nascita della nostra nuova identità non viene da Praga né dalla questione del Centralismo Democratico, né dalla incapacità di analizzare lo sviluppo concreto dei capitalismi, né dall’emergere del berlusconismo o dei mal definiti “populismi”, né tanto meno dallo sport prediletto dalla sinistra, unirsi e dividersi continuamente.
Comincia all’indomani del secondo conflitto, quando i gruppi dirigenti comunisti, non solo italiani, si interrogano. Si interrogano su una questione cruciale: nei paesi socialisti i rapporti di produzione sono stati rovesciati. Ed è un fatto. Dovrebbe conseguirne di per sé una estensione della democrazia e del benessere, e la liberazione delle classi subalterne, anche se con riflussi e nuove avanzate. Invece non è così, nei Paesi Socialisti le classi subalterne soffrono, e lo sviluppo è inceppato. In Cina, dopo i bagliori della Rivoluzione Culturale, succede la stessa cosa: la ricreazione finisce presto. Poi, dopo Budapest, ecco Praga, la scoperta delle dittature in Romania e altrove nell’ex URSS, e poi l’evoluzione cinese. Nei paesi capitalistici (anche Taiwan e Sud Corea), invece, il progresso sembra preludere a maggiori spazi di sviluppo e democrazia. Cosa succede?
La strada che Marx e l’Ottobre hanno indicato al movimento operaio sembra improvvisamente fantasiosa, se non pericolosa. Durante la lotta alle armate naziste la questione era stata giustamente messa da parte, ma a partire dagli anni ’50 l’interrogativo diventa inquietante. Non è una questione di poco conto: il puro rovesciamento dei rapporti di classe non è più la chiave miracolosa. E non lo sarà mai più, si teme. Non bastano le spiegazioni sul burocratismo, sullo stalinismo e così via: la scelta di vie alternative, di “un altro comunismo” comincia con quell’interrogativo. Non si spiegano altrimenti il dibattito di quegli anni (condotto da dirigenti più dubbiosi e seri di quanto ci piace rappresentare), e le lotte interne al Pci, esplose con la scomparsa di Togliatti. E non è uno scontro a somma zero: è messa alle porte non solo la prospettiva rivoluzionaria, è messa alle porte anche “la via italiana”. I riformismi si tramutano in migliorismi, senza prospettive di cambiamento.
Il secondo fatto macroscopico è la questione dello sviluppo italiano degli anni ’60. Sembra improvviso, dilagante, inatteso e appagante. E non bastano a spiegarlo la presenza di qualche risorsa mineraria e molte risorse turistiche, né il sostegno Usa: è uno sviluppo reale, di economia, di popolazione, di prodotto. Ma rimane arretrato. E’ arretrata la modalità di accumulo del capitale, è arretrato il rapporto di produzione, è arretrata la composizione organica del capitale, è arretrato l’investimento in tecnologie, scambiato per investimento in marketing e efficacia commerciale. Il sostegno americano esclude i comunisti dalla guida del Paese, ma l’impulso è decisivo. L’Italia si sviluppa (meccanica, elettromeccanica, siderurgia, chimica), ma comincia da subito una diversificazione sconsiderata: la finanza sembra più attraente. I saggi sono maggiori, gli investimenti minori e flessibili; ed il conflitto di classe è marginalizzato. In altri casi, invece (Germania e Giappone, perdenti e smantellati come noi) gli investimenti diventano produttivi, ogni azienda manifatturiera sviluppa anzitutto il proprio “core”, e a saggi di profitto assai più bassi: l’accumulazione è più lenta ma è stabile e si risolve in nuovi investimenti. La poderosa macchina accumulatrice del capitalismo, in Europa, è ripartita. Nel nostro Paese cominciano invece le “congiunture”. E una serie di tentativi di riordino: le nazionalizzazioni, l’istruzione di massa, le infrastrutture, la questione meridionale, fino al sostegno pubblico alle imprese maggiori e alla privatizzazione dietro compenso (anziché a titolo oneroso). E una serie di iniziative autonomistiche: la svalutazione programmata per sostenere l’export e gli investimenti esteri, la scala mobile per alimentare la domanda interna (oltre che per isolare il conflitto derivante dall’inflazione), fino al rapporto diretto di Mattei con i Paesi del petrolio e ai tentativi protezionisti.
E’ da quel tipo di sviluppo che nasce un motivo serio di scontro interno al gruppo dirigente: è la questione del sostegno operaio alla modernizzazione tal quale, apparentemente foriera di sviluppo. E’ uno scontro concreto, che influenza alleanze, scelte internazionali, rapporto con il sindacato. Neanche qui lo scontro è a somma zero: ne esce sconfitta l’idea di scomposizione e ricomposizione dei gruppi sociali come leva di egemonia. Prevale il senso della “politica”: i “movimenti” e le alleanze fra classi sono altro, disturbano la manovra. Al massimo si appoggiano i movimenti antifascisti. Io non penso, lealmente, che gli Amendola, i Napolitano, i Pajetta, i Trombadori siano stati solo una “destra” opportunista; ho combattuto le loro ragioni in Sezione, all’epoca, e lo farò ancora, ma capisco il fondamento.
Credo che è da questi due fatti principali, l’inquietudine sui socialismi mancati e la scelta rivelatasi via via perdente di affidarsi alla “politica” emarginando le spinte, che nasce un’area “pensante” all’interno del Pci, si chiami o meno “sinistra”, ingraismo, o come si voglia. Un’area pensante che il gruppo del Manifesto incarna e che ancora oggi, fallimento dopo fallimento, gode di prestigio e potenzialità. E credo che se lavoriamo bene, raccogliendo questa eredità, siamo contagiosi. La razza speciale di cui parlava Togliatti adesso siamo noi: dobbiamo dircelo. E dircelo con una punta di orgoglio.
Tuttavia, e qui il ragionamento deve farsi necessariamente impietoso, credo che sia il momento – insieme a molte autocritiche - di un ripensamento sul “che fare” concreto, di fronte allo spostamento rapidissimo del baricentro mondiale verso i Paesi emergenti e di fronte alla desertificazione domestica di fabbriche e popolazione operaia, e di fronte alla contraddizione in cui sono convinto si sia già avviluppato il “sistema” occidentale. Altrimenti ci riduciamo a inseguire fantasmi e nostalgie di bandiere e inni, o farsi vittime di intellettuali e sociologi liberali mascherati da geni finanziari di sinistra, dai saperi arguti, ficcanti, improduttivi e disarmanti.
© 2013-2017 FondazioneLuigiPintor
tutti i diritti riservati
CF: 97744730587 – P.IVA: 12351251009

