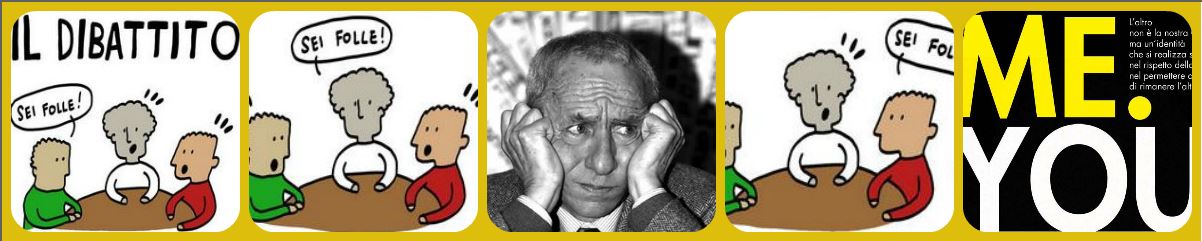
Ripartire non è impossibile
(seconda parte)
di Michele Di Lecce
Luciana Castellina ricostruisce, su questo sito, il senso dell’esperienza manifesto-pdup, come già nella prefazione al libro su Magri. A poca distanza, sul sito di Magri, Famiano Crucianelli lancia di fatto un’esca per l’ipotesi di una ricostruzione unitaria. A commento del suo intervento alcuni compagni propongono analisi e ipotesi di una freschezza e originalità che avevamo dimenticato, pur sapendo di esporsi così a montagne di critiche. I Circoli sardo, bolognese ed altri, e questa Fondazione, stanno riaprendo un dibattito di respiro, utilizzando la rete. Dalla redazione del quotidiano arrivano segnali di ricerca di una ricomposizione, che è anche nei nostri cuori. La nostra vicenda politica non è dunque conclusa.
Vorrei sottoporre ai compagni tre possibili temi per la ripartenza: la questione della crisi, la questione della legalità/corruzione, la questione istituzionale. Delle ultime due mi riprometto di parlare un’altra volta. La prima, riguardante la crisi, richiede una pur breve analisi. Analisi di parte, non saprei fare altrimenti.
Mi pare che il “sistema occidentale” si sia avviluppato in una nuova contraddizione, imprevista e tutta interna. Sotto lo schiaffo della crisi finanziaria (dei subprime nel 2008 e del debito pubblico adesso), gli Stati sono costretti - essi stessi - a demolire i meccanismi del consenso.
Sta cioè crollando la percezione secolare che gli Stati costituzionali garantiscono stabilità, opportunità di promozione sociale, difesa della proprietà privata e legalità.
Mi viene in mente un intervento di Ingrao ad un convegno del 1969, mi pare in Via dei Frentani (poco prima della “radiazione”, altrimenti non sarei potuto entrare). Le parole esatte mi sfuggono, ma il concetto – in risposta ad obiezioni sulla timida mobilitazione di massa - era chiaro: “le classi sociali sono scomposte.”
Ciascuno è, in una situazione, lavoratore subordinato (impiegato o operaio), in un’altra lo stesso soggetto è datore di lavoro (ad esempio del portiere condominiale o della domestica), in un’altra ancora lo stesso è investitore (delle proprie eccedenze di reddito), in altre lo stesso soggetto è piccolo proprietario (della propria abitazione o di un antico lotto coltivato nella zona di origine), in altra ancora è un lavoratore autonomo, con istinto all‘evasione (un secondo lavoro, la partecipazione ad una attività commerciale) e così via. Tale circostanza, di appartenenza contemporanea “di ciascuno” a diverse classi, costituisce lo strumento principale di mantenimento del consenso al sistema da parte delle classi subalterne. Esse sono infatti sulla difensiva dei propri microprivilegi conquistati nella posizione contemporanea di piccola borghesia e soprattutto attratte dalla proclamata possibilità della propria ulteriore promozione, anche mediante fiammate di lotta sindacale espresse nella situazione di lavoratore dipendente. Garanzia di ciascuno nelle diverse situazioni è la cosiddetta “legalità”, strumento di certezza e di consolidamento della posizione acquisita.
La scomposizione e ricomposizione delle classi sociali è dunque compito arduo, ci ammoniva, prerogativa di Partito e intellettuali.
Adesso c’è però un fatto nuovo: la crisi finanziaria e la conseguente ricerca famelica di liquidità. E’ così partita una patrimoniale sulla massa delle famiglie, la soppressione del diritto, finora sostanzialmente esplicito, all’evasione fiscale dei piccoli, l‘attacco diretto alle conquiste salariali e sindacali. Ognuna di queste manovre trova la stessa giustificazione “tecnica”: consentirà una futura crescita.
Sia nella situazione di piccoli borghesi sia nella situazione di lavoratori dipendenti, i singoli cominciano a sentire che lo Stato non li garantisce più. Si inceppa il meccanismo del mantenimento del consenso. Chiamandolo “coesione sociale”, Stato e tecnici di governo – da Tremonti, a Monti a Letta - lo ripuliscono dalla connotazione anticapitalistica, ma ne intuiscono lo stesso la precarietà. Ed infatti non toccano i privilegi delle fasce a reddito altissimo, indice e conseguenza del potere oligarchico da queste acquisito all’interno del sistema, paventandone la possibile pericolosa opposizione. I governi sequenziali dei tecnici, insomma, conoscono bene il tavolo immorale su cui giocano. La politica tedesca, in questo, c’entra poco.
Cosa è successo, perché la ricerca di liquidità si spinge fino a minare la “coesione“? C’è una crisi energetica in atto, una rincorsa prebellica, una ricostruzione postbellica da finanziare? Soprattutto: si crea spazio per una azione politica nostra che metta i piedi nel piatto?
Il processo di nascita e sviluppo della crisi è in verità facilmente leggibile senza ricorrere a categorie astratte sulla finanziarizzazione del capitale e sul mutamento dei rapporti di scambio ineguale.
I paesi del petrolio hanno accumulato nei decenni scorsi ricchezze finanziarie immense. Monarchie e dittature, anziché elevare il livello sociale e sviluppare l’industria manifatturiera - che avrebbe comportato la nascita di proletariato interno, spinta alla democratizzazione e rischio di impresa - hanno invece riversato liquidità, fatte salve le spese per armamenti e per il proprio irrinunciabile lusso, nei mercati finanziari occidentali puntando sulla loro crescita e scaricando scientemente su di questi l’onere di generare ricchezza (aggiungendo valore mediante i processi produttivi) e senza rischio di squilibri domestici. Ne hanno tratto ulteriore liquidità e l’hanno riversata di nuovo. I paesi emergenti hanno profittato e insieme alimentato a loro volta il processo, con capitali altrettanto corposi, ma insieme sviluppando immense produzioni competitive (per investimenti ben più che per basso costo della manodopera: la RAM, lo schermo e l’hard disk del Pc che avete davanti - prodotti tecnologici, non cappellini intrecciati - sono fatti in Cina).
Ma la contraddizione era alle porte: azioni, derivati, fondi, hanno raggiunto - con l’iniezione costante di liquidità - rendimenti elevatissimi, rendendo da una parte sconveniente, al confronto, l’investimento manifatturiero (che via via si è prosciugato), e insieme alimentando un sistema bancario restio al rischio di credito - appunto poco remunerativo - ma in espansione numerica paradossale. Migliaia e migliaia di esercizi commerciali di quartiere sono stati rilevati per aprire “sportelli” in grado di predare la domanda dei risparmiatori, ormai adusi, visti i presumibili “rendimenti“, all’investimento in azioni e derivati. Alla fine è nata una specie di gigantesca catena di Sant‘Antonio che ha necessità continua, a pena di interruzione, di nuovi adepti. Un’intera classe, medio-bassa e subalterna, attratta dalla facile speculazione, si è rapidamente trasformata. Ha legato il proprio interesse sempre più “all’andamento della borsa“, cioè - più precisamente - alla necessità inconsapevole che nuova e crescente liquidità, alimentando la domanda, rialzasse il valore del proprio presunto patrimonio, ormai costituito solo da rendiconti bancari sul proprio pacchetto diversificato, spacciato dai mass-media (e vissuto) come simbolo della propria promozione sociale. Impiegati, operai, dipendenti pubblici e semipubblici, insegnanti, funzionari, piccoli commercianti, pensionati: insieme classi subalterne e contemporaneamente micro-speculatori alla ricerca del profitto utilizzando il proprio risparmio.
Anziché porzioni di immobili o lotti, milioni e milioni di famiglie hanno insomma “comprato” pezzi di carta, che hanno lo stesso valore dei francobolli d’annata: il loro valore cresce esclusivamente se altri filatelici si affacciano a comprarli. E nessun titolo (salvo le azioni ordinarie all‘atto dell‘emissione) trasforma la collocazione sul mercato in investimento produttivo. Una volta acquistato, il titolo può solo essere rivenduto, sperando di collocarlo successivamente a prezzo maggiore. Insieme è nata un abnorme massa di addetti allo scambio che assorbe costantemente una quota dell’incremento di valore dei titoli gestiti o scambiati, senza produrre, nello scambio e nella gestione, alcun valore aggiunto reale: il “titolo” non è una merce normale; possiede la proprietà di poter essere venduta, ma non quella di essere a sua volta consumata per produrre altra merce di valore maggiore. Riproduce solo se stessa. L’incremento del suo valore in unità monetaria, in sostanza, non aumenta la ricchezza reale. Alimenta però il consenso delle classi subalterne e risparmiatrici al sistema e tende a ridistribuire reddito in favore delle fasce che già ne hanno eccedenza. Non solo: il mantenimento e la riproduzione della massa di personale addetto, cresciuta a dismisura come i locali in cui opera, grava inesorabilmente sul sistema produttivo reale, il quale ultimo continua invece ad essere, al confronto, sempre meno remunerativo e via via compresso: le banche, prestando alle imprese manifatturiere, lucrano sempre meno che investendo in fondi. E alla fine ne inventano di propri, intrecciando sostegno al debito sovrano a spregiudicate acquisizioni di crediti, inesigibili perché materialmente inesistenti. Senza credito alle imprese si moltiplicano crisi domestiche, delocalizzazione e outsourcing, e diminuiscono gli investimenti in modernizzazione e tecnologia. Dunque il “mercato” azionario, che ne doveva essere l’artefice e lo stimolo, comincia a frenare l’aumento di efficienza del sistema produttivo. E continua a crescere.
Tuttavia il processo si arresta. La richiesta di acquisto di titoli comincia a diminuire (per tante concause, alcune note altre dibattute). E appena comincia la diminuzione, anche di poco, il processo muta carattere, si inverte: il valore dei titoli comincia a scendere, il fondo che li contiene è solo un scimmia di patrimonio, perché il titolo diventa invendibile. Finisce la sua utilità: non si tramuta in liquidità per l‘acquisto di beni e servizi, rimane “in portafoglio”, il valore scende sotto il prezzo di carico, il patrimonio si rivela una beffa.
Di più: gli “investitori internazionali” si liberano della spazzatura. Utilizzano metodi sofisticati di previsione e perciò “anticipano”. I loro portafogli si svuotano di titoli, facendone precipitare il valore e aspirando liquidità da destinare ad altro in pochi secondi (l’acquisizione di baby multinazionali e brand, gioielli produttivi ad alto profitto, catene di servizi, ecc.). Così la catena speculativa si inceppa, la massa di personale addetta è eccedente, crollano i profitti delle banche, che fino ad allora avevano lucrato facilmente, e infine crolla la disponibilità ad acquistare titoli di Stato. Quest’ultimo deve così alzarne il rendimento per acquisire la liquidità necessaria al proprio funzionamento. Il debito statale cresce ulteriormente e gli “investitori stranieri”, temendo l’insolvenza, si ritirano anche dalle remunerative aste dei titoli di Stato.
E’ questo il prezzo del sistema globalizzato liberista, del “mercato” senza regole, solo aggravato dalla gestione più o meno allegra dei governanti. Qualcuno si autoassolve con locuzioni furbesche (attacco speculativo all’euro, contagio dai paesi insolventi, eccesso di welfare, rigidità del fattore lavoro, sfiducia ingiustificata “dei mercati“, speculazione delle agenzie di rating e così via), spie di impotenza e di terrore della defenestrazione. E comincia la produzione di ricette da parte di economisti e geni della finanza (dal divieto di vendita allo scoperto, agli eurobond, alla moneta unica di scambio internazionale, fino - terra terra - all‘attacco a tassisti e barbieri evasori), tutte tarate sulla necessità anzitutto di mantenere il mercato finanziario “così com’è” e, come fosse scontata la sequenza, di rilanciare conseguentemente la “crescita”.
Ognuna delle “ricette” si autoinceppa a sua volta: il sistema è intrecciato a livello internazionale, non ne può prescindere. Il metodo Roosevelt non è applicabile: il diktat implicito nella globalizzazione - che era sembrata la lampada di Aladino da strofinare a piacimento - non è esorcizzabile, uscirne ormai significa isolare tutto il sistema interno, ripensarlo. Ripensare i rapporti di classe, per dirla nel linguaggio nostro, scardinando il profumato potere delle caste politiche, tecniche e finanziarie, costruito sui ceti medio-alti. L’Italia “ce la può fare”, si dice, nel senso di “si può sanare la crisi senza intaccare il cuore del sistema finanziario” (e della filiera di comando e di consenso che genera). Al limite ci aiuti la Germania.
Schema banale, superficiale e di parte, ma sta di fatto che le misure dei governi (Monti in particolare) costituiscono un attacco a tutte le figure in cui si sfaccetta il singolo e di cui parlava Ingrao. Sia nell’attacco ai microprivilegi, sia nella garanzia di possibile promozione sociale sia, non ultimo, nella legalità: l’emergenza finanziaria diventa fonte del diritto, istanza superiore, l’Ilva ne è l’esempio.
Questa mi pare la prima battaglia di cui possiamo farci carico: il tema della ricomposizione di classe e della accelerazione della crisi del consenso. In favore della ricostruzione di una “coesione” nuova e diversa.
Ho pensato a due ipotesi di campagne concrete in merito, di cui dovrebbe farsi carico il giornale e noi in rete, sostenute dal dibattito fra i compagni più esperti in materia.
La prima: non c’è quasi nessuna famiglia italiana che non abbia pezzetti di risparmio investiti in fondi di qualche tipo. Ecco: il giornale e noi possiamo farci carico di una battaglia culturale per spezzare la catena dell’investimento speculativo, che lega queste famiglie al sistema malato e al dramma della perdita del risparmio. L’articolazione pratica potrebbe essere, sul giornale, una pagina quotidiana intera che riporta un dibattito permanente contro il rischio dell’investimento finanziario tal quale. Che spieghi come tutti i cosiddetti fondi di investimento contengono pericolosi derivati, fino a fondi che scommettono sul fallimento di altri. Che se la banca offre un fondo con una parte di rendimento garantito, allora il costo dello svincolo assorbe tutto il rendimento, e così via. Una campagna martellante destinata - detto in chiaro ed esplicitato - “alle famiglie”. Che riporti in un riquadro un appello a “investire”, casomai lo si ritenesse, soltanto su azioni “ordinarie” e, rigorosamente, solo “all’atto dell’emissione”, unica circostanza che consente di trasformare il risparmio in investimento. E solo azioni che consentono di diritto il voto nelle assemblee. Insomma acquisire molecole di proprietà reale dell’azienda. Escludendo a priori l’investimento in società puramente finanziarie, l’investimento in società che non abbiano alcune caratteristiche di sicurezza (bastano 2-3 indici tipici, facili da spiegare e da fornire sulla stessa pagina). Sulla stessa pagina magari l’elenco delle azioni di prossima emissione e i relativi indici di sicurezza. Mai, dunque, in fondi di investimento o bancari indiretti, più o meno bilanciati. Nel caso, investimenti in titoli di Stato italiani, del genere “pronti contro termine“.
Si tratta, come si capisce, di una specie di imposizione dal basso del recupero della funzione classica del sistema bancario, capace di mettere all‘angolo la speculazione sul risparmio delle famiglie e di promuoverne la destinazione all‘economia reale. E anche uno strumento di recupero di consenso, di autorevolezza e di lettori. Comprendo che molti compagni puristi inorridiscono all’idea che “il manifesto” di Pintor contenga indicazioni del genere. Propongano allora un’altra strada di intervento, non l‘inazione e le lagnanze.
La seconda proposta. Una campagna per la redistribuzione forte del “sacrificio”, una campagna di “equità compatibile”. Concepita nei termini seguenti, in modo che sia insieme strumento di propaganda e di ricomposizione etica: un mese di stipendio di tutti ad un tetto massimo, diciamo 2.500 euro netti (o 3.000, fa lo stesso). Tutti, dipendenti pubblici e privati, manager, autority, generali, deputati, magistrati, tutti. Il resto nelle casse dello Stato, metà con destinazione riduzione del debito e metà con destinazione “investimento”. Un mese di “sacrificio equo”. Un mese solo (o anche due scaglionando), e poi tutto come prima. Se si fanno i conti, sono cifre enormi e non attaccano i bassi redditi. E‘ una opzione chiara, senza equivoci. Con 2.500 euro netti si vive decentemente, e chi ha un reddito superiore ha ben disponibilità a superare “il mese di sacrificio”, basta rinunciare a cambiare il SUV o la parure o rinviare un paio di cene ipercostose. Non si parli della “benefica” propensione marginale al consumo dei redditi alti, perché sarebbe immorale.
Con quali argomenti ci si può opporre ad una campagna del genere, lanciata dal manifesto?
Ben pochi, credo, e se la destra (o il PD) li evoca, se ne prende la responsabilità di fronte a milioni di italiani, schiaffeggiati senza ritegno per salvare manager di banche, speculatori e pluri poltronieri di Stato.
In questa sorta di campagna, del “mese di equità forzata”, avremmo inoltre un alleato potentissimo: la generazione di giovani e meno giovani cattolici contagiati dalla spinta etica, sottolineata anche dal nuovo papato. Una spinta nutrita dal rifiuto delle mafie, delle perversioni del berlusconismo e della sua corte assetata di lusso, successo e potere sbandierati come valori, dal rifiuto dello scempio ambientale e della disuguaglianza, del privilegio e del razzismo. Di più: un contagio reciproco per noi, direi strategico vero, forse destinato ad un’alleanza culturale stabile partendo da un tema concreto. Prima che un improvviso Savonarola o un imam poco ascetico impugni la questione della secolarizzazione etica e rovesci violentemente tutti i tavoli, con forza di gran lunga maggiore della cosiddetta “antipolitica” grillina.
Una campagna così si può lanciare, a costo di apparire estremisti, e acquisire visibilità e lettori.
Nel ‘77, in un’assemblea infuocata a Ingegneria a Roma, lanciai a fine intervento l’ipotesi scandalosa, concordata con i nostri compagni di Economia, che il “movimento” incontrasse il Sindacato di Polizia, anziché tirare molotov ai celerini, suscitando l’ovazione dopo due secondi di terribile silenzio. Piperno – che veniva ad ascoltare le assemblee, delegando poi gli interventi agli adepti - lasciò l’aula infuriato, seguito dalla sua corte minacciosa, che si voltava e urlava facendo il segno della pistola puntata mentre l’assemblea intonava “fuori-fuori”. Non se ne fece poi niente, ma divenne una parola d’ordine, ripresa da giornali, tv e altre facoltà; e spezzammo l’isolamento in cui ci aveva cacciato l’Autonomia.
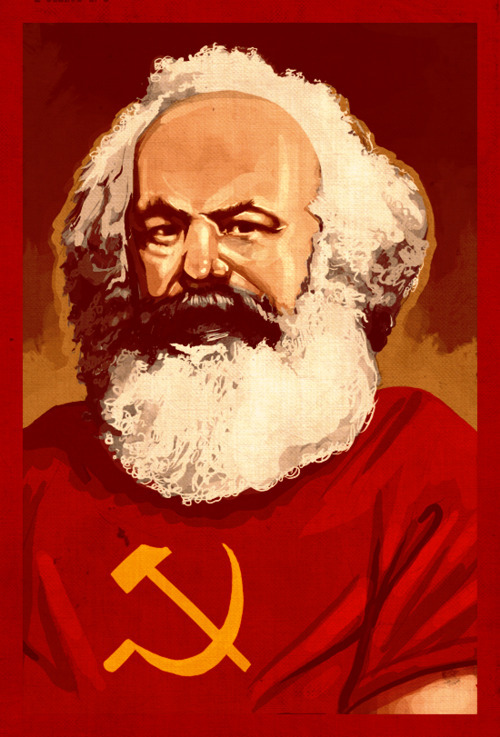 LA PAGINA DEL DIBATTITO - INDICE INTERVENTI
LA PAGINA DEL DIBATTITO - INDICE INTERVENTI
© 2013-2017 FondazioneLuigiPintor
tutti i diritti riservati
CF: 97744730587 – P.IVA: 12351251009

