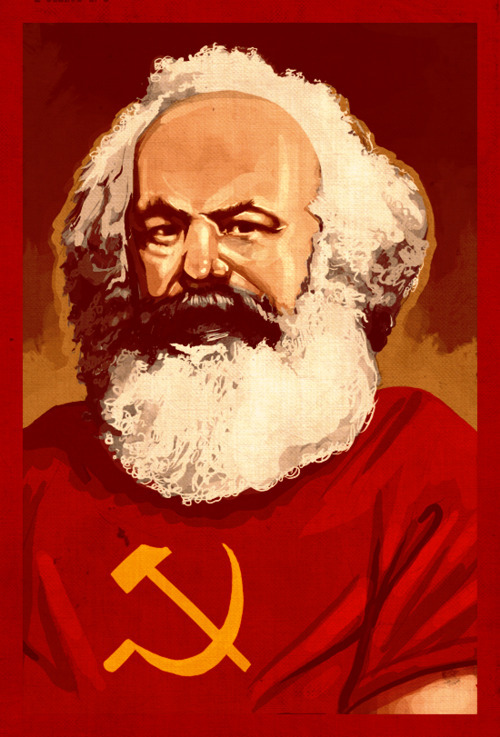di Giacomo Casarino - 24 settembre 2013
Voglio “volare basso”, anche a costo di apparire poco o per nulla costruttivo: forse politicamente scorretto sì, ma senza alcuna intenzionalità inutilmente recriminatoria. Gli interventi che mi hanno preceduto erano unificati sotto la sigla “dalla nostra storia alla sinistra di oggi”; di più, Filippo Maone sosteneva la necessità di “approfondire i nessi tra la fase storica da cui abbiamo preso le mosse e quella in cui ci accingiamo a camminare”. In realtà, della nostra storia intesa sia in senso largo (la sinistra di classe” di un tempo) sia in quello più ristretto del nostro gruppo politico, non si può dire che si sia trattato in termini analitici, specie in rapporto ai “punti di caduta” negativi che abbiamo dovuto registrare. Eppure è da qui che occorre ripartire, ma non certo per fustigarci o per un’insana pulsione “archeologica”.
Ancora: sento parlare e leggo (Enrico Pugliese in questo stesso dibattito) di Manifesto3 ed allora viene spontaneo di chiedermi: con quali risorse intellettuali, con quali idee-forza, con quale aggiornamento, se non radicale revisione, di un bagaglio teorico-culturale e pratico che ha contrassegnato la nostra storia e che è venuto via via esaurendosi o è stato ricacciato nell’oblìo?(per evidenti ragioni escludo dalla disamina la seconda serie della Rivista del Manifesto, non ascrivibile in toto alla nostra “eredità” storica).
Perché pur sempre di una sconfitta portiamo il retaggio, anche se l’eclisse del nostro “fare politica” come gruppo organizzato, nella seconda metà degli anni ’70, non mi pare paragonabile per gravità delle conseguenze future (schematicamente, passaggio alla lotta armata, da un lato, vasta dispersione di energie militanti, dall’altro), derivanti rispettivamente, dalla coeva evaporazione dei “gruppi” e dal posteriore suicidio del PCI.
In altri termini, è possibile pensare ad una rifondazione del “quotidiano comunista” o anche di una rivista scissa dalla riformulazione di un un’ipotesi di lavoro condivisa? Di un’ipotesi di lavoro, dico, non di un’impresa organizzata con finalità partitiste; della formazione cioè di un reticolare “intellettuale collettivo” che metta in circolo l’elaborazione di categorie analitiche e di un lessico comune, che ci consenta, nella dialettica delle posizioni, di riclassificare e di modificare di volta in volta le nostre inevitabili divergenze?
Uno sguardo alla storia ed un bilancio sommario si rivelano preliminari, come ho precedentemente accennato. La nostra esperienza come gruppo organizzato unitario terminò, nelle polemiche, attorno al 1977-78, con conseguente polarizzazione e separazione delle due tendenze emerse, tra chi credeva di poter mettere a frutto politicamente - ciò che avvenne nel 1984 -, nelle file di un Pci che pareva stesse rinnovandosi, il pur rilevante strappo teorico e ideologico realizzato con la fondazione del Manifesto e chi, invece, ribadiva le permanenti ragioni di un’autonoma collocazione politico-ideale della nostra “eresia”. Manco a dirlo, la storia di ieri è tutta incorporata in quello che soggettivamente siamo diventati oggi, nelle nostre individuali diversità e sensibilità, direi, permanenti.
Risalendo per un attimo ai primordi, al ’69-’70 delle radiazioni e della rivista, va detto che l’autonomia operaia espressa dall’”autunno caldo” si depotenziò e rifluì, rinnovandolo, nel sindacato, ma avendo come referente politico il vecchio PCI, non essendosi formato un soggetto politico di massa in grado di esprimere e rilanciare la spinta operaia. Inoltre, e forse in ragione di questa assenza, la struttura consiliare, la cui esistenza consideravamo la conditio sine qua non per fondare un partito di alternativa[1], si ridusse a braccio del sindacato.
Quanto alla crisi di sistema, essa c’è stata a livello mondiale, a partire dalla metà degli anni ’70, ma è stata gestita – e per certi aspetti provocata – dall’avversario di classe (controrivoluzione thatcheriana ecc.), facendo sprofondare il terreno su cui noi volevamo costruire un nuovo percorso per la rivoluzione in Occidente ed in Italia. La caduta del muro, l’assetto unipolare del mondo che ne è conseguito (peraltro oggi in crisi) e, infine, il trionfo della globalizzazione hanno finito per capovolgere il quadro e le premesse operative da cui eravamo partiti. Le nostre difficoltà ed i contrasti (interni al giornale) si sono poi acuiti con la scomparsa del PCI.
Quando noi, in Italia, ci stavamo arrovellando (ed accapigliando) sulla natura e sulle implicazioni del movimento del ’77, qualcuno (e ne va dato atto apertis verbis all’intuito di Luciana Castellina) ci ammoniva che “il vento dell’Ovest (cominciava a ) soffiare più forte”. Forse una maniera come un’altra per avvisarci che, dopo le turbolenze maoiste e post-maoiste, dovevamo guardare all’Occidente ed ai rivolgimenti che la zona centrale dell’economia-mondo ci avrebbe inevitabilmente riservato di lì a poco, dopo i traumi dell’inconvertibilità del dollaro e della crisi petrolifera: avvio di un ciclo complessivamente regressivo, forse a scala secolare (F. Braudel), che avrà una prima, ma eclatante esplosione globale nella crisi sistemica ancora in atto, sotto forme mutevoli.
Tuttavia permanevano e si saldavano nel nostro pensiero la percezione (che ritenevamo soggettivamente diffusa) tanto della natura antisistemica del ’68 quanto del carattere inedito della crisi, combinato disposto che preludeva, con tutta probabilità, ad un passaggio epocale, a quella che chiamavamo “maturità del comunismo”, l’apertura cioè di una fase di transizione. E non già, soprattutto, ad una positiva, non recessiva ristrutturazione capitalistica, come tante altre se ne erano verificate in passato: se non vado errato, la crisi in atto era ritenuta di questo tipo da Foa e dai compagni provenienti dallo PSIUP.
La concettualizzazione della maturità del comunismo dava adìto ad una distorsione ottica del tempo storico, ad una proiezione immediatista della sua validità e applicabilità politica, tanto che, a posteriori Valentino Parlato può giungere a scrivere che “le Tesi per il comunismo da cui aveva preso avvio il via la nostra impresa si erano rivelate errate […]”[2]
Un generoso tentativo, unico in Italia, di “agganciare la storia” (pessima metafora oggi in auge in riferimento alla mitica ”ripresa”) fu il convegno milanese del 1980 promosso dal quotidiano (alla vigilia della marcia dei quarantamila della FIAT!) Intitolato a “liberare il lavoro o liberarsi del lavoro”, che faceva seguito al convegno del 1975 “uscire dalla crisi del capitalismo o dal capitalismo in crisi ?”. Questi problematici interrogativi conseguivano al dibattito, più asseverativo,-1974-75-, pubblicato dal quotidiano su “spazio e ruolo del riformismo”.
Ma a me sembra di ricordare che il focus sull’informatica e sull’automazione fu ricondotto al quadro analitico dell’organizzazione e della divisione del lavoro in fabbrica in una prospettiva ancora tutta fordista: non intravedemmo le ricadute che le “nuove tecnologie” avrebbero consentito in termini di trasferimento in tempo reale dei capitali, della conseguente mondializzazione dell’economia, con la derivante imposizione neoliberista dei vincoli legati alla competitività, della pratica delle delocalizzazioni produttive, ma anche dell’insorgenza di speculazioni finanziarie che sarebbero in misura esponenziale cresciute nei decenni a venire fino a determinare gigantesche bolle portatrici di un potenziale esplosivo quale mai si era visto.
Bisogna riconoscere che tutto ciò cambiò il volto del capitalismo. A distanza di oltre quarant’anni dalla sua formulazione risulta, ahimè, palesemente falsata la tesi secondo cui il capitalismo si sarebbe manifestato incapace “di ridurre a sua immagine l’universo sociale”[3] : quel capitalismo che, del resto, si conferma come il peggior nemico di se stesso (Marx), in quanto intrinsecamente degenerativo e distruttivo delle basi stesse della vita. Insomma, omologazione totalitaria e anarchia economica, pervasività della tecnica e, dal punto di vista dei soggetti, assoluta perdita di “senso”: caratteri compresenti che connotano alla radice l’odierno finanzcapitalismo.
Raffaele K. Salinari, attraverso una metafora olistica, è giunto a paragonare il l’attuale capitalismo al cancro (nella sua, originaria e prevalente, versione mortale): "è l'unico morbo che distrugge se stesso facendo morire il corpo che lo ha generato" . Ed aggiungeva: "quando ci si chiede come mai i padroni della finanza sono così "degenerati" nelle loro speculazioni [...] e non esitano ad avvelenare l'intero pianeta è perché essi non si sentono appartenere alla stessa razza, il liberismo ha rotto da tempo tutti i vincoli della "solidarietà di specie" e di quella biosferica [...]”
Dunque, una distanza abissale rispetto agli scenari che ci si prospettavano all’origine del Manifesto e che costituivano i presupposti per il decollo della nostra impresa, che puntava ad escludere un esito caotico e/o catastrofista, che invece oggi si ripresenta prepotentemente, anche sub specie d una conflagrazione mondiale (vuoi bellica vuoi ambientale).
Nell’attuale stadio della crisi sistemica siamo giunti al più alto, direi esplosivo, livello di contraddizioni finora conosciuto, credo di poter dire (di ripetere: altri molto più autorevoli di me l’hanno segnalato) che siamo passati da una crisi di sistema ad una “crisi di civiltà”, che è qualcosa di diversamente grave rispetto alla “crisi dello sviluppo” su cui discettammo negli anni ‘70: quando ne scrisse nel 1935 lo storico liberale olandese Huizinga era la premonizione di una catastrofe che si andava pericolosamente avvicinando, il secondo conflitto mondiale provocato dalla barbarie nazista. Crisi di civiltà, particolarmente dell’Occidente, senza peraltro pronosticare, di conseguenza, come fa la destra più becera, un’invasione musulmana e un Occidente islamizzato.
In fin dei conti, il “male assoluto” rappresentato dal nazismo, con annessa carneficina mondiale, si è consumato come espressione di un potere del tutto arbitrario e feroce nel giro di due soli decenni (ed in presenza di una potenza irriducibilmente antagonista, l’Unione Sovietica). Oggi viceversa andiamo incontro ad una decadenza, a una deriva progressiva che, ai vari livelli, tende a consolidarsi, non trovando “potenze” in grado di bloccarla.
Sul piano strettamente economico, siamo in presenza di una crisi dal cui tunnel non si vede la luce, passibile, per giunta, di recidive ravvicinate in ragione del fatto che la classe dei proprietari globali non sa come uscirne (e quindi riproduce la crisi allargandone la portata devastante) e non si danno dei plausibili correttivi interni al sistema, come fu a suo tempo il keynesismo. In una situazione, inoltre, che vede la sinistra anticapitalista complessivamente minoritaria (o assente, come in Italia) e, comunque, priva di una strategia convinta e incisiva.
Ne consegue che la crisi galoppante macina a favore della destra populista. Notare: non solo Alba Dorata in Grecia e altre formazioni analoghe nel Nord Europa, ma l’eventualità che in Francia il Front National divenga il primo partito, insediato ormai in territori in passato storicamente collocati a sinistra). Non si può dunque escludere che al totalitarismo del mercato neoliberale si coniughino forme politiche decisamente fascistizzanti: “socialismo o barbarie”. Dove magari le ”larghe intese” (non solo italiche), in ragione della loro pervicace politica di austerity e di privatizzazioni, si facciano pronubi, novelli Hindenburg, di regimi aberranti, fuori controllo, nel loro sviluppo, da parte delle stesse classi dominanti che in qualche modo ne siano i promotori.
I focolai di resistenza non costituiscono un fronte di lotta, nemmeno difensivo. Certo, il rilancio del conflitto, la cifra che ha contraddistinto gli anni ’70 in Italia, ma più in generale il Novecento, è la chiave di volta: ma come ricomporre la solidarietà di classe minata dalla concorrenzialità operaia imposta dal Capitale? Quando peraltro il lavoro, almeno in Occidente, per quanto affannosamente cercato dalle classi subalterne ai fini della sopravvivenza, non è più il connotato in cui il soggetto-lavoratore, la persona in generale, in primis e spontaneamente si riconosce? Quando la coscienza di classe si è, per così dire, ristretta nel recinto della singola azienda, insorgente nel momento del pericolo (mobilità o delocalizzazione)?
Quando il lavoratore-consumatore [4], è prigioniero di un mercato del lavoro globalizzato quanto assolutamente deregolamentato, in cui ha buon gioco l’ideologia individualista sparsa a piene mani dalle varie e alterne correnti populiste e nazionaliste, mentre la nozione di “collettivo” pare completamente essersi eclissata?
Certo, l’Impero (centro, gli Stati Uniti) vacilla, mostra le sue crepe, ha sempre minor presa come comando unico: ma questo significa semplicemente che gli imperialismi, lungi dal declinare, si moltiplicano, identificandosi anche in alcuni dei Paesi BRICS. A questo riguardo, qual’é la valenza della massiccia penetrazione cinese in Africa che, pare (per quanto incredibile,) giunga ad immaginare il trasferimento, nel lungo periodo, di alcune centinaia di milioni di popolazione eccedente in quel continente?
Assistiamo, quanto a re-insediamenti industriali e a investimenti finanziari all’estero, ad un fenomeno inedito e non ancora studiato - certamente presente in Italia, non so altrove -, e cioè al fatto che non esiste più soltanto la unidirezionalità costituita dalle delocalizzazioni dal centro alla periferie del mondo, in ragione del minor costo del lavoro, ma si verifica anche l’intervento di Paesi (effettivamente “in via di sviluppo”: tra poco lo saranno alcuni Stati africani che registrano un tasso di crescita superiore a quello dei BRICS) e di capitali che rilevano aziende decotte o in via di fallimento, asiatici: indiani soprattutto, ma non solo).Talora, a onor del vero, al solo scopo di disfarsene in breve lasso di tempo. Così come si assiste ad investimenti, ad esempio, di capitali angolani nel disastrato Portogallo e la parallela immigrazione di cittadini portoghesi nelle ex-colonie africane.
Si disegna così, tra metropoli ed ex-periferie, un paesaggio industriale e, più in generale, economico frastagliato e a “macchia di leopardo”, il che dovrebbe indurre gli analisti a congedarsi, con maggiore convinzione, dal concetto legittimante di “sovranità” statuale, imperando, tra l’altro, con ovvie ricadute politiche, il comando del FMI e del WTO (e in Europa della Troika). Di fronte, del resto, ad un diritto internazionale, reso del tutto obsoleto e ormai in fase de iure condendo (basti pensare all’ONU e alla sua mai attuata riforma) sul terreno pace/guerra: laddove è sempre più difficile distinguere il “di dentro” dal “di fuori”[5], e cioè guerre civili da guerre tra Stati, essendo le prime talora combattute per interposte “fazioni interne”, ma alla fin fine, se non eterodirette, risultanti vantaggiose per talune potenze o alleanze interstatuali.
Ma questa eventuale sovraordinazione delle rivolte e delle guerre civili - dove fa la sua comparsa una inedita potenza armata non territoriale, come Al Qaeda - da parte di interessi “altri”, non deve esimere le forze internazionaliste dall’interrogarsi e dal prendere tempestivamente posizione (e da appoggiare), quando tali conflitti nascono, le forze che combattono per la democrazia , anche se il loro orientamento socialista può non essere dato o non ancora maturato: ciò che non è successo per la Siria, quando i nove mesi di manifestazioni pacifiche anti-Assad non hanno scomposto, hanno lasciati scettici i rivoluzionari e gli “antimperialisti”, salvo ridestarsi essi dal sonno della ragione quando un aperto intervento militare dall’estero sembrava prendere consistenza.
In Italia, il sentimento di rivolta, che si è concretizzato in Grecia, in Portogallo e in Spagna, in lunghi scioperi e in grandiose manifestazioni di massa, non si è dato, e non è certamente questa la sede per dirimere il rebus. Adesso però, oltre al fronte caldissimo del lavoro e dell’occupazione che si acuirà con tutta probabilità in autunno, ci attende, da parte governativa, una massiccia ondata di privatizzazioni (e di svendite): quel tanto di beni comuni che resta è messo in pericolo dalle compatibilità di bilancio, al fine dichiarato di scongiurare un esplicito commissariamento da parte dell’Unione Europea, se non addirittura il rischio di un ravvicinato default.
La sfera dei beni comuni è da difendere non solo per salvaguardare l’welfare residuo (il che non è poco), ma anche perché costituisce il terreno su cui si potrebbero impiantare e sperimentare inedite forme di gestione dal basso, di partecipazione diffusa e di conflitto: tutti ingredienti necessari perché una ri-nascita della Politica possa decollare, e, nel contempo, si possa superare, una volta fondata la categoria di “comune” al di là di ogni concezione giuridica proprietaria, la distorta e borghese dicotomia tra proprietà privata e proprietà pubblica[6].
Certamente, questa scommessa è del tutto interclassista e i comitati di gestione (dell’acqua o di altro bene) non possono essere il surrogato della democrazia diretta espressa dai Consigli degli operai e dei produttori in genere. Ma non credo che di ciò occorra scandalizzarci: non accettiamo forse da tempo l’alleanza - anzi, qualcosa di più, l’integrazione nel blocco sociale antagonista) - con forze ed esperienze che si muovono entro quella visione lnterclassista propria all’ambientalismo e al femminismo?
Dunque, una redistribuzione di potere che anticipa e reclama di per sé una redistribuzione della ricchezza, uno stop alle dinamiche che continuano ad allargare il divario tra i (sempre più ) poveri e i (sempre più) ricchi. E che minano la civile e pacifica convivenza sociale, provocando legislazioni securitarie e misure di ordine pubblico che sconfinano con “guerre a bassa intensità”. Un impianto più marcatamente repressivo occorre infatti al sistema per consentire al neoliberismo di “riprendere la marcia a velocità di crociera” (S.Halimi), nonostante le patenti manifestazioni di fallimento che ha offerto nel corso dell’attuale crisi.
J P Morgan si è fatto l’alfiere dell’attacco finale al modello sociale europeo, prendendo di mira le costituzioni del Continente troppo impregnate, a suo dire, di socialismo: la revisione di larga parte della nostra Carta si colloca in questo ambito, cui aderiscono, volenterosi complici, tanto il PDL quanto il PD: verrebbe così a compimento lo stravolgimento del nostro assetto democratico, destinato ad essere soppiantato da un regime contrassegnato dall’alternanza (o dalla discordia concors) tra i due maggiori partiti e soggiogato dalla governance delmercato.
Il teatrino della politica segnato tanto dalla passivizzazione degli elettori, mediaticamente omologati, quanto dal crescente astensionismo diverrebbe così del tutto estraneo ed impermeabile al conflitto sociale. A questo terreno costretto a configurarsi come extraparlamentare dobbiamo fare riferimento, non senza tener d’occhio la pur fittizia e fuorviante dialettica tra i partiti-istituzioni: infatti, non stiamo vivendo una, tutto sommato, tranquilla navigazione entro un patto sociale sia pure in via di evoluzione, ma in una tempesta interminabile che ci vuole naufraghi e sottomessi.
Oggi è all’ordine del giorno, più che mai, la difesa della nostra Costituzione repubblicana, la più invisa, probabilmente da JP Morgan: una revisione della seconda parte, di vasta portata, diciamo pure la formulazione di un nuovo assetto ordinamentale, perseguito per giunta attraverso la deroga a quella che è la più rigida e cogente delle norme, l’art. 138. Tuttavia non possiamo far finta di ignorare che la Costituzione oggi vigente non è già più quella entrata in vigore nel gennaio 1948, sotto molti rispetti, e neppure lo è più lo spazio di sovranità colà sotteso, che, in ragione dell’art. 11, è venuto restringendosi lungo il processo che ha portato nei decenni all’integrazione europea. Valga, a titolo di esempio, il diritto di revisione da parte della Commissione Europea o di un suo organismo circa la legge di bilancio (detta altrimenti legge di stabilità). Inoltre, è in vigore il rispetto del patto di stabilità a tutti i livelli istituzionali, da quello statale a quello comunale, entro i parametri stabiliti dall’Europa.
Tutto ciò ha avuto come coronamento, per eccesso di zelo italico bipartisan, la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio. Abbiamo idea di quante disposizioni costituzionali, soprattutto in materia di politica sociale, mette in discussione e rende vane il pareggio di bilancio? E ancora: se non si dichiara di mettere a tema e, poi, di voler cancellare questa norma (e il fiscal compact che l'accompagna), se non si chiarisce che il debito pubblico non è esigibile, non esiste difesa della Costituzione che tenga. Rischieremmo di difendere un fortino, una casamatta già espugnata, ridotta ormai a un residuo del tempo che fu. Logica vuole che la difesa/applicazione della nostra Costituzione passi per l'(auto)distruzione di questa Europa monetarista e la costruzione di un'ALTRA Europa , con cui i nostri principi costituzionali possano essere in sintonia.
Di questi “scambi”, di queste deviazioni (o cambi di paradigma) mi pare che abbiamo bisogno se non vogliamo che il nostro treno deragli in una landa sconfinata e deserta.
Giacomo Casarino - Università di Genova
© 2013-2017 FondazioneLuigiPintor
tutti i diritti riservati
CF: 97744730587 – P.IVA: 12351251009