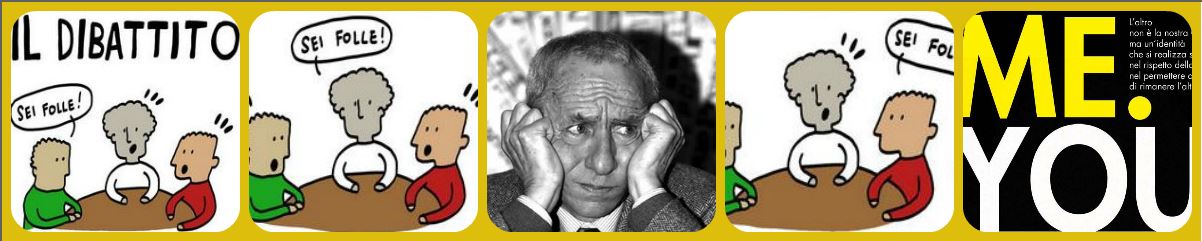
IL PESO ESIGENTE DELLA NOSTRA STORIA...
CONSIGLI MAO(N)ISTI
di Filippo Maone
Concordo con il giudizio di Valentino sulla profondità della crisi in cui versa da più di cinque anni l’intera economia mondiale, sia sul versante finanziario che su quello produttivo, e con effetti più o meno disastrosi a seconda dell’armatura di partenza di ogni singolo paese. Ma il maremoto si avverte ovunque ed è più forte dei tentativi convulsi di placarlo, cosicché non si vede a tutt’oggi un’efficace via d’uscita. È vero, questa crisi sembra peggiore di quella del ’29. E perciò si giustifica l’allarme, su cui Valentino insiste, circa i pericoli gravissimi di vario genere che in essa stanno maturando, facendo temere nei punti più fragili, per ragioni strutturali e storiche, come l’Italia, un devastante disfacimento della democrazia. Tanto più a rischio, come l’esperienza insegna, quando l’impoverimento rapido di vasti settori di ceto medio ne facilita la disponibilità a prestarsi da masse di manovra per fascismi e populismi d’ogni risma. Temo fortemente che si stia avvicinando una stagione carica di questa gravità, magari in forme mai sperimentate finora. Gli ultimi sviluppi estivi della situazione italiana ci impongono estrema attenzione sul punto. Anzi, come si diceva una volta: massima vigilanza. La crisi non è dunque soltanto di tipo economico ma generale, di ordine sociale, civile, politico. E anche di idee, che siano all’altezza della necessità di contestare e riprogettare.
Curiosa evoluzione della storia. Siamo a un passaggio d’epoca, iniziato con il fallimento del primo gigantesco tentativo di contrapposizione alla filosofia e alle pratiche del sistema capitalistico, che avendo stravinto lo scontro è rimasto in conclusione dominatore assoluto sulla scena mondiale. Eppure, una volta sbaragliati i più fastidiosi e pericolosi antagonismi, l’universale trionfatore – anziché avvicinare il mondo alle promesse ‘sorti magnifiche e progressive’ – ha dato rapidamente segni di insufficienza cardiaca. Mostrando, inoltre, non solo di non riuscire ad equilibrare gli esaltati princìpi dell’individualismo – soprattutto nel campo dell’attività economica – con i bisogni vitali di tutte le popolazioni del pianeta, ma anche di perseguire la soluzione delle crisi attraverso un continuo svigorimento dei processi democratici, considerati ormai sostanzialmente incompatibili con lo ‘sviluppo’, perché d’intralcio al libero espandersi dello spirito d’impresa.
Se questo tema scompare dalla riflessione delle forze politiche che si definiscono di sinistra, tutta la loro azione finisce con l’infiacchirsi, se non addirittura snaturarsi, come purtroppo sta accadendo da tempo. Mentre invece anche i programmi e le pratiche riformistiche, sempre esposti al rischio d’esser resi innocui dalla mancanza di energia conflittuale, potrebbero trovare consistenza e luce, ma solo alla condizione di tenere costantemente in esercizio l’aggancio con l’ispirazione ugualitaria e con i grandi ideali di giustizia sociale (se è ancora concesso di pronunciare la parola!). Alla condizione, cioè, di non inibirsi la facoltà di esercitare pressione, con “intelligenti” forzature, sulle “compatibilità” del sistema, anche in tempi non propizi a rilevanti conquiste, così da dare senso non disfattistico agli eventuali, probabilmente inevitabili, compromessi successivi. Come, ad esempio, si seppe fare in complesso negli anni difficili del secondo dopoguerra.
Se si sceglie di stare dalla parte dei lavoratori e di battersi per una società che non li condanni al destino dell’eterno sfruttamento, bisogna innanzitutto guardare a fondo nel meccanismo che ne pretende la riduzione a merce, analizzarlo nei modi in cui reagisce a particolari eventi, nei diversi comparti e in aree geografiche disomogenee, e infine non cessare mai di studiarlo nelle sue mutazioni più o meno accelerate, soprattutto in rapporto al progresso tecnologico.
La Fondazione intestata a Luigi Pintor, a cui tutti noi abbiamo aderito, corre così il rischio di rendere – per così dire – sistematica quella certa frettolosità con cui è nata, finendo col frazionare ulteriormente, anziché collegare, le già troppo segmentate schiere di una sinistra in pena. Basta osservare le perplessità suscitate nei ‘circoli del manifesto’, con cui pure si stava lavorando. In particolare in quello di Cagliari, ma non solo. Mi permetto allora di mettere in guardia tutti noi dall’assomigliare, fino poi a diventarlo davvero pur senza volerlo, a uno degli infiniti gruppuscoli che hanno costellato il firmamento di una storia a noi contigua, ma da cui abbiamo sensatamente tenuto sempre a distinguerci. Significherebbe imprigionarsi da soli in stanze chiuse, dove le cose dette, quand’anche giuste, lì resterebbero a marcire di inefficacia, e non soltanto perché inascoltate fuori dal recinto, ma soprattutto perché le menti che le producessero si atrofizzerebbero presto per insufficiente circolazione di ossigeno.
Tutto considerato, io dunque non ritengo che, allo stato, ci siano le basi minime per proporsi di mettere in piedi una nuova impresa politico-culturale, pur se di nobile ispirazione, in grado di svolgere un ruolo positivo nella disperante situazione in cui ci troviamo, sia quella generale che quella più limitata, tutta interna ai nostri circuiti. E altrettanto sconsigliabile, a mio parere, sarebbe un’altra ipotesi: l’eventuale intenzione di prepararsi ad accendere un contenzioso amministrativo – che poi passerebbe facilmente alle vie legali – con l’attuale gestione del “manifesto”, sul terreno della proprietà della testata.
Se capisco bene, è questa l’opinione – in certa misura anche autocritica – di una buona parte dei redattori che hanno ritirato la firma a seguito della resistenza della direzione ad avviare un dibattito sulla linea editoriale e sui nodi politici di fondo, più volte sollecitato da loro stessi oltre che da Valentino Parlato e, con un lungo articolo di qualche settimana prima, da Rossana Rossanda: non proprio gli ultimi arrivati. E credo che sia anche l’opinione – in questo caso senza ombra di autocritica, e inoltre diversamente argomentata – di tanti compagni di altro filone, quello di derivazione Pdup, a cui ancora brucia lo strappo che compimmo “noi del giornale” nel lontano 1978 (!) e che loro chiamano scippo, non senza qualche comprensibile motivo (come l’amata Luciana Castellina non cessa di ricordarci ad ogni piè sospinto).
Devo confessare che a tratti, negli anni passati, anch’io ho pensato che “il manifesto” avesse esaurito la sua carica propulsiva, per cui non mi sono del tutto estranei alcuni argomenti di chi oggi sostiene di dovere lucidamente prenderne atto, per dedicare ogni stilla di energia a preparare nuove iniziative e imprese collettive, più adeguate al tempo che viviamo e ai materiali che la lunga crisi non ha finito di produrre. Ma proprio il modo in cui la crisi si sta scaricando in Italia, soprattutto nel quadro politico e sui gangli fondamentali della democrazia conquistata (come dimostra la virulenza di una destra di sostanziale natura fascista, ben tollerata, proprio come ai bei tempi, e persino condivisa in molte sue motivazioni, dallo stato maggiore dei liberali “perbene”, vedi il “Corriere della sera”), mi ha persuaso che l’assenza di una voce come quella del “manifesto”, con tutti i suoi limiti ma ancora unica – considerata la cacofonia prodotta da una ex sinistra balbuziente – sarebbe una sciagura. E imperdonabile sarebbe la responsabilità di chi la provocasse o non facesse di tutto per evitarla.
Il problema, dunque, si riassume oggi per noi nella crisi drammatica del giornale che ha portato alla spaccatura della redazione, e in come provare a superarla. Non è solo per ragioni di età e di lunga e ricca storia comune se io solidarizzo con la maggioranza della vecchia guardia che si è opposta alla variazione di umori, prima ancora che di linea, impressa dalla nuova direzione: linea non ancora ben precisata, ma umori che rinviano a una visione liquidatoria (superficialmente, a mio giudizio) di alcuni basamenti ideali da cui è partita l’avventura del “manifesto”. Beninteso, si tratta di un’intenzione del tutto legittima ma molto criticabile, perché avviata senza la necessaria discussione, sempre elusa e sostanzialmente rifiutata, almeno nelle forme dovute all’importanza della questione. Ma con uguale sincerità non posso tacere che non mi ha convinto il successivo comportamento tenuto dai compagni con cui, nel merito, mi trovo in sintonia. Ad essi addebito d’avere sottovalutato quanto ne avrebbe sofferto una larga fetta di lettori, rimasti spiazzati e ammutoliti dalla loro scelta di lasciare il campo. Le loro mosse finali mi sono apparse in verità precipitose, e per di più prive in partenza di sbocchi positivi.
A maggiore ragione va criticato l’atteggiamento tenuto in tutta la vicenda dalla direzione del giornale e dal blocco di compagni che l’hanno sostenuta. Qualcuno potrebbe rimproverarmi di osservare le cose dall’esterno. Ma, in un caso come questo, osservare dall’esterno non toglie valore alle opinioni, perché l’oggetto di cui si parla è un bene che travalica i margini di competenza di chi ha l’incarico di gestirlo pro-tempore: certamente con tutti i poteri connessi all’esercizio della funzione, ma anche con l’avvertenza di non dimenticare mai da quale enorme collettivo proviene la propria legittimazione, qual è l’esercito che negli anni ha permesso di superare ogni difficoltà con un sostegno fatto di idee, di passione e di sacrifici, a volte molto grandi. Tutt’altro discorso è quello che ho sentito riecheggiare in questa occasione, relativo alla difesa dell’autonomia della redazione nei confronti di chiunque volesse imporre dal di fuori indirizzi e contenuti. Il grande collettivo di cui parlo, con i suoi modi di esprimersi, non va assolutamente confuso con la segreteria di un ipotetico partito. Il quale peraltro, ci tengo a precisare, avrebbe anch’esso titolo per discutere degli orientamenti, qualora partecipasse alla compagine editoriale. Ma in forme acconce, che non saprei definire meglio di come feci in un paragrafo delle note che servirono a convocare, nell’autunno del 1997, le riunioni preparatorie della “rivista del manifesto”. Mi si perdoni l’autocitazione. Riferendomi indirettamente alle nostre dolorose diatribe di vent’anni prima, mi permisi allora di ammonire che, quand’anche al fianco del quotidiano si fosse riformata una sponda non solo ideale ma operante politicamente nella società, diciamo pure un partito, esso ≪dovrebbe riuscire ad avere un respiro tanto largo da non pretendere di piegare alle contingenti direttive di azione o alle alterne esigenze di organizzazione, grande o piccola che sia, la voce e i toni e i ritmi di uno strumento sui generis come un (il) giornale. Il quale intanto può risultare utile (e non poco) alle comuni battaglie, in quanto sia lasciato libero da pesantezze che lo porterebbero ad affondare≫. E in conclusione volli precisare che non stavo indicando ≪atti di generosità, ma un modo ponderato e intelligente di intendere la convenienza politica≫.
Non mi sfugge che quanto io sto auspicando possa incontrare robuste resistenze. Ma mi domando: quali sono le alternative? Quelle appena abbozzate da alcuni compagni del gruppo che ha lasciato il giornale sono troppo vaghe per tracciare davvero una strada praticabile. E quella messa effettivamente in pratica dai compagni che stanno gestendo oggi la testata mostra visibilmente la precarietà del suo equilibrio, benché possa vantarsi con giustificata soddisfazione di avere assicurato finora la continuità delle pubblicazioni,. Ma fino a quando si potrà reggere e con quali prospettive? l’intuito, fondato su lunghe esperienze e su tanti segnali attentamente valutati, mi dice che non tarderanno a ripresentarsi problemi di dimensione superiore alle proprie virtù. C’è troppa sproporzione tra le forze e i mezzi, da una parte, e il peso esigente della nostra storia e della turbata fedeltà dei lettori dall’altra: vale a dire con ineludibili, incombenti questioni politiche ed editoriali.
Sia ben chiaro: io non sto facendo un appello alla “pacificazione” priva di contenuti, saltando a piè pari sulle ragioni serie, molto serie, che hanno portato alla frattura nel collettivo redazionale. Niente affatto. Anzi io penso che una ricomposizione della crisi potrà avere un segno positivo solo se si sarà capaci di affrontare apertamente i nodi di fondo del contendere, non solo e non tanto negli incontri ristretti tra i protagonisti più implicati (sempre utili, naturalmente), ma soprattutto coinvolgendo tutti i collaboratori, i più e i meno assidui, di nuova e di antica data, e il maggior numero possibile di lettori, a partire dai nuclei di “eroici” sostenitori organizzati nei circoli. Promuovendo cioè una discussione pubblica di ampiezza straordinaria sulle pagine del giornale, che ad essa dovrebbe dedicare tutto lo spazio che merita (una pagina al giorno? due?) per tutto il tempo che servisse a non strozzarla. Immagino una lunga sessione di dibattito che aiuti a ridisegnare i caratteri del quotidiano, i suoi fondamenti ideali e il suo modo speciale di essere un soggetto politico, e ad approfondire i nessi tra la fase storica da cui abbiamo preso le mosse e quella in cui ci accingiamo a camminare; che inoltre, ma non secondariamente, offra spunti utili a perfezionare le tecniche di indagine e ad aguzzare la vista sulla realtà per ottenerne una più aderente traduzione giornalistica; che infine dia nuovi stimoli per riprogettare l’impianto dell’impresa editoriale, puntando all’incontro con il digitale in dosi ben maggiori di quelle finora assimilate.
Si avrà il coraggio di avviare questa operazione? Ci vogliamo provare davvero? Sono quasi certo che essa avrebbe come conseguenza non soltanto una riduzione del danno, ma addirittura una moltiplicazione di effetti positivi in tante direzioni. Allora sì, a quel punto si potrebbe lanciare con buona probabilità di successo una super-straordinaria sottoscrizione per l’acquisto della testata. Che sta ancora lì in attesa, nelle mani dei liquidatori, senza che nessuno dei separati eredi sia stato finora in grado di riscattarla.
Filippo Maone, 20 agosto 2013
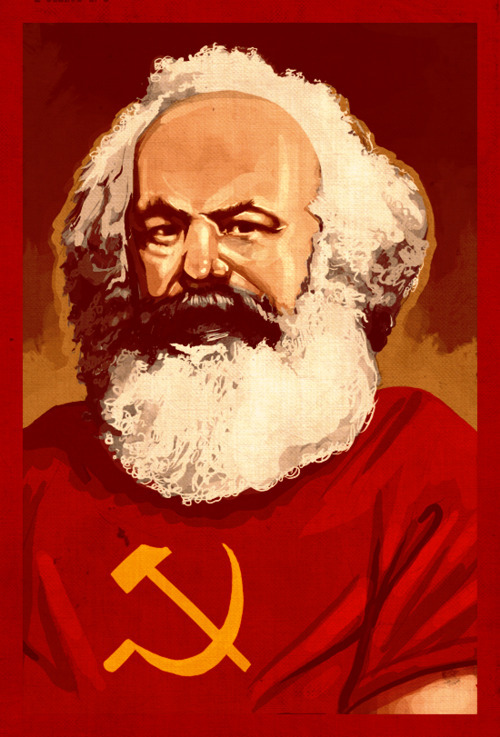 LA PAGINA DEL DIBATTITO - INDICE INTERVENTI
LA PAGINA DEL DIBATTITO - INDICE INTERVENTI
© 2013-2017 FondazioneLuigiPintor
tutti i diritti riservati
CF: 97744730587 – P.IVA: 12351251009

