
Per una nuova proposta politica
Luigi Pintor
QUALI COMPITI ?
(numero 1 gennaio 1970)
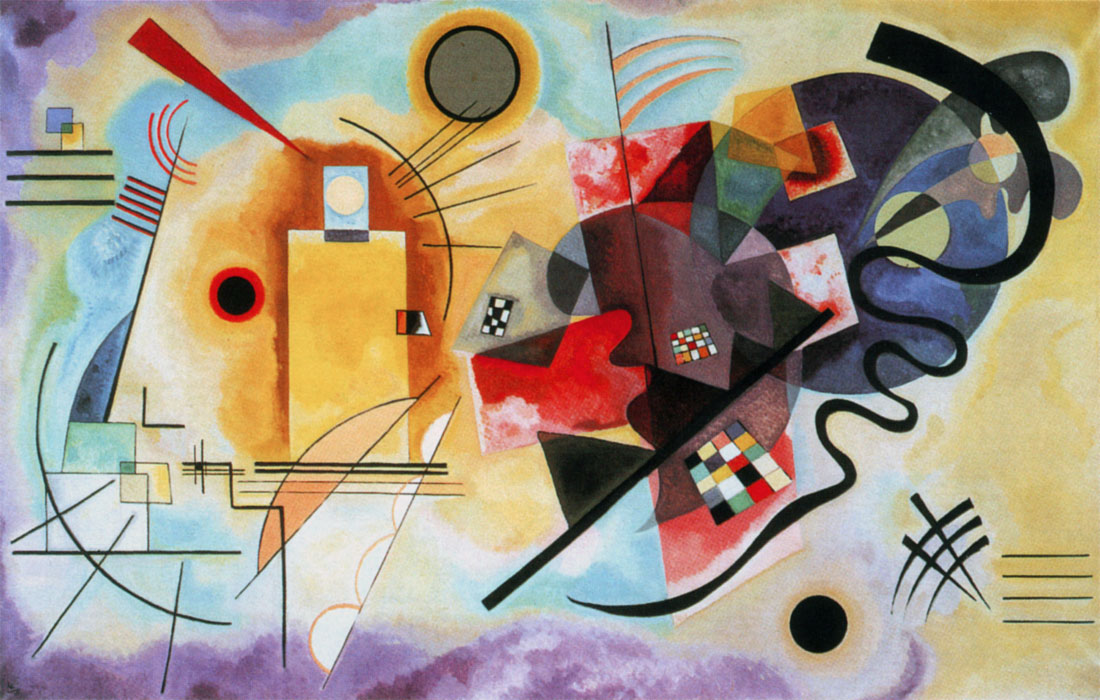
Nessuno ha negato e nega, meno che mai le forze della sinistra, che il movimento di lotta di questi mesi abbia vuto una carica rivendicativa e una potenzialità politica, una maturità di obiettivi e di forme di lotta, senza o con pochi precedenti in Italia e nell'occidente europeo. Lo si era previsto, ammaestrati dal 1968, e la precisione ha trovato per una volta conferma.
Il bilancio dei contratti sindacali, dell'autunno caldo o maggio strisciante, può essere più o meno felice, più o meno critico, ma la forza del movimento, malgrado i suoi scompensi, non è da nessuno revocata in dubbio, ma via via si può dire che ci si sia avvicinati, su quest'onda, ad un esito politico in qualche modo adeguato e degno?
Al contrario il vuoto di prospettiva, l'incertezza sull'avvenire, l'oscurità degli orizzonti, sono evidenti. E sebbene non siano una novità, oggi tanto più colpiscono n quanto le volontà e le forze che reclamano un salto li qualità sono venute in chiarissima luce, hanno consumato una grande esperienza collettiva, hanno saggiato e accresciuto la vulnerabilità dell'avversario. Eppure ci si prepara a scontare, quasi fatalmente, una :ontroffensiva dei gruppi dominanti e dello schieramento « moderato », grettamente conservatore o apertamente reazionario, che ha il suo fulcro nella DC e nella socialdemocrazia, i suoi strumenti nell'apparato statale, i suoi ispiratori nel mondo atlantico.
Questa controffensiva già trova spazio: si sperimenta la repressione, con meccanismi polizieschi, giudiziari e amministrativi che da trent'anni sono uguali a se stessi, che hanno scelto come primo bersaglio la sinistra extraparlamentare ma procedono naturalmente a macchia d'olio; si riaffaccia puntuale il ricatto, padronale e governativo, degli squilibri monetari e produttivi, per imporre una rigida riorganizzazione del lavoro e del suo sfruttamento e una piena restaurazione del dominio imprenditoriale; si ritesse un intrigo politico che combina a seconda della vocazione dei progressisti, l'allarmismo delle bombe e il riformismo mercanteggiato, la repressione e la tregua sociale, l'eccitamento dei benpensanti e il dialogo sotterraneo a sinistra.
Che cosa si contrappone da sinistra a tutto questo? Nello scontro diretto col padronato, la libertà di azione post-contrattuale conservata dai sindacati ha un valore di principio ed è una premessa tecnica per opporsi alla rivalsa padronale. Ma è appunto una premessa, che potrà essere vanificata se il processo di unificazione dal basso, le forme di organizzazione autonoma e gli embrioni di democrazia diretta che le masse sono andate sperimentando, non cresceranno, fino a diventare la struttura portante dell'intero movimento di classe; non solo sindacalmente ma politicamente, per uno scontro permanente e una alternativa di potere dentro e fuori la fabbrica, dentro e fuori la scuola, nel corpo della società e delle istituzioni statali.
Non solo diversa, ma opposta, è però l'ipotesi politica che da sinistra si continua a coltivare, con tenacia pari alla miopia. Da un lato, ci si trova imbrigliati di nuovo in una battaglia di retroguardia contro il più squallido degli esiti immaginabili, quello quadripartito: e per quanto un simile schieramento difficilmente possa ritrovare la forza per una repressione generalizzata o la fantasia per un recupero riformista, tuttavia le bombe di Milano e gli incredibili messaggi presidenziali sono bastati a riaccreditarlo, relegando i « nuovi rapporti » tra opposizione e maggioranza dietro quinte polverose.
D'altro lato, è difficile stabilire una gerarchia di decenza tra le « alternative » previste: non più la chimera di un governo DC-PSI dotato di un programma decoroso, che nessuna persona assennata ha mai preso sul serio, ma una avventura elettorale come sbocco di un crescente allarmismo e di un riflusso delle lotte; oppure una sopravvivenza dell'esperienza monocolore, questa o un'altra, che molti tacitamente prediligono contando di volgerla ai propri fini. La difesa dell'ordine repubblicano, per usare l'infelice espressione televisiva che ha riassunto i compiti dell'opposizione di sinistra per il 1970, e l'attesa di un governo genericamente «orientato a sinistra», ecco il bilancio politico disarmante che si dovrebbe alla fine ricavare dalle lotte di questi mesi ed anni, lasciando il « blocco storico » della rivoluzione agli atti congressuali.
Al di là delle ricognizioni in questo sottobosco, la realtà è in breve questa: che la divaricazione tra scontro sociale e momento politico («le lotte oggi, la politica dopo»), il rifiuto della sinistra tradizionale di cogliere la novità storica della crisi in atto e di fondarvi la propria politica, il vuoto di una strategia per il potere e di una forza politica che vi si richiami, riducono il movimento di lotta, per quanto ricco, a provvisoriamente placarsi entro l'orizzonte rivendicativo; e fanno coincidere la fine di un biennio di contestazione generale con una fase politica paludosa come nel 1947, nel 1954, nel 1963. Proiettati su un terreno tra i più avanzati del dopoguerra, il movimento e la sinistra ufficiale non sanno come procedervi, e non solo per i ritardi accumulati in un ventennio, ma per le scelte ambigue (o fin troppo esplicite) che proprio negli ultimi tempi hanno prevalso.
L'unità politica della classe e delle sinistre anticapitalistiche è avanzata solo nelle enunciazioni, non è stata con nessun atto perseguita, e si conferma incompatibile con una concezione eclettica e diplomatica delle alleanze. Le nuove forme di iniziativa e organizzazione autonoma delle masse, sindacali e soprattutto politiche, sono rimaste per gran parte il prodotto di una creazione spontanea, nonostante le presunte intuizioni e aperture del XII Congresso del PCI. Il riflusso del movimento studentesco non è stato arginato né tantomeno invertito, senza troppo rammarico dei molti che fin dall'inizio avevano visto nella contestazione giovanile un fastidioso ostacolo alle pratiche riformiste. La saldatura tra le avanguardie operaie, studentesche, .tecniche e intellettuali, come anche tra Nord e Sud, non ha trovato espressioni durevoli perché non è stata, salvo qualche eccezione, neppure cercata. Il processo centrifugo nel mondo cattolico, nel movimento aclista, nella sinistra socialista, non ha trovato i nuovi terreni di aggregazione che domanda. L'autosufficienza del PCI non ha trovato né cercato dei correttivi, si è anzi insuperbita con le « epurazioni » fino a sconfinare, in qualche caso, nella « boria » bollata da Gramsci.
***
In questo quadro si fa pressante come mai la necessità di una risposta, di una proposta politica nuova della sinistra di classe a se stessa e al paese, di una linea unificante delle forze sparse, di una prospettiva mobilitante e perciò di potere. Non si tratta solo, come due anni fa, di cogliere tutto il valore di rottura dell'ingresso tumultuoso delle nuove generazioni sulla scena politica; né solo di attrezzarsi, come sei mesi fa, per una fase di lotta operaia che si sapeva avrebbe investito il sistema. Si tratta di colmare un vuoto che già in queste settimane somiglia, e nei mesi prossimi promette di somigliare ancor più, a una voragine. Precisamente questa è l'esigenza che ci ha portato allo scontro all'interno del PCI. E questa è la ragione per cui possiamo già oggi verificare un fatto politico molto più rilevante di quanto non prevedessimo: non un nostro, isolamento, ma il crescere intorno a noi e alle posizioni del Manifesto di una molteplicità di occasioni e sollecitazioni di incontro e di azione comune; con molti compagni tuttora impegnati nell'organizzazione comunista, con altri gruppi che se ne sono distaccati o ne sono stati esclusi, con i giovani che si raccolgono nei gruppi minoritari di varia tendenza, con collettivi studenteschi e quadri operai, con settori della sinistra cattolica e socialista che hanno rotto con l'esperienza d'origine. Incontri di diversa natura, assemblee pubbliche e riunioni di lavoro, promossi da forze diverse, ma tutti animati dal bisogno di ricercare e di trovare una più convincente risposta politica, e anche organizzativa, ai problemi che dividono e tormentano il movimento.
Nel nostro ultimo editoriale, abbiamo scritto di ritenere che i ritardi accumulati sul piano teorico e politico non saranno mai colmati se non ci si orienta a una comune ipotesi di lavoro e in un rapporto nuovo con il movimento le forze sociali e politiche disponibili. Per quanto parziali e difficoltose, le prime esperienze pratiche ci confermano nel convincimento che lo spazio politico per questo lavoro esiste ed è esteso: non solo perché le contraddizioni tra il movimento e la meschinità dell'ipotesi riformista lo spalancano, ma per la tensione critica che esiste all'interno della sinistra tradizionale e dei sindacati, per le scelte già compiute in ordine sparso da forze diverse, per la ricchezza di energie e di quadri. La tesi corrente secondo cui, col distacco dall'organizzazione maggioritaria della classe, non esiste per le minoranze altro destino che di ridursi a gruppi intellettuali, non è che un sottile ricatto, un invito all'inerzia, o un sospetto facilitato dal carattere « elitario » che ha in partenza, forzatamente, qualsiasi battaglia minoritaria: non era questa — fatte le debite proporzioni — l'accusa rivolta all'Ordine Nuovo?
Vero è che questa esigenza di una nuova proposta politica, e anche questa ricchezza di energie e di sollecitazioni, potrebbero essere un dato ancora inerte o un fenomeno solo quantitativo. Ma si accompagnano, invece, al maturare di una convergenza di giudizi sui veri nodi da affrontare, al di là dei dispareri anche profondi sul modo di scioglierli.
Nei mesi che hanno visto accendersi la polemica fra il gruppo dirigente del PCI e il Manifesto non ci è accaduto di sentir seriamente contestare la sostanza dei punti discriminanti che avevamo per parte nostra fissato: sulla natura della crisi che scuote i paesi dell'est europeo, e la necessità di una critica di classe all'assetto di quelle società; sul rifiuto del riformismo e l'attualità di un processo di transizione al socialismo; sui caratteri del partito rivoluzionario in una società complessa e in una fase storica tanto diversa dal passato. Oggi, non solo verifichiamo che una contestazione su questi terreni e una difesa della « tradizione » suscitano incredulità non appena escono dal chiuso degli apparati, ma che più vasta del previsto è l'area delle forze che in quei punti discriminanti si riconoscono. E vi si riconoscono non solo in negativo, nel rifiuto degli schemi correnti di interpretazione e di comportamento politico, ma secondo una comune direzione di ricerca, alla luce di quanto ogni giorno accade sulla scena mondiale e nazionale.
Sulla scena mondiale, la linea generale della politica sovietica è indifendibile. Quale messaggio, quale indicazione viene per le grandi masse dai gruppi dirigenti dell'URSS? Poco più di un anno fa, una tragedia come l'invasione della Cecoslovacchia ha potuto essere accreditata e.perfino favorevolmente interpretata da molti come risposta al pericolo tedesco, garanzia di continuità delle conquiste socialiste minacciate dall'imperialismo; oggi, mentre la « normalizzazione » infierisce sui consigli operai e sugli studenti, e persino sui comunisti greci rifugiati, la ricerca del compromesso con la socialdemocrazia tedesca impegna la diplomazia sovietica con uno zelo e una deferenza pari alla furia che guidò i carri armati contro le scelte autonome del partito comunista cecoslovacco, pari all'avversione politica e alla minaccia militare contro il comunismo cinese. Un orientamento internazionale del tutto coerente con l'involuzione interna del gruppo dirigente sovietico, che non avrebbe gratificato proprio il Manifesto di un attacco postumo se non per proclamare, anche in questo modo, la sua ostilità alla democrazia operaia, al socialismo come regime di transizione, a ogni prospettiva comunista di liquidazione dei prerilegi.
Sulla scena nazionale, il rifiuto del riformismo trova continuo stimolo nella vicenda politica che le avanguardie e le masse direttamente vivono, al di là di ogni disputa teorica sul nesso tra democrazia e socialismo. Com'è possibile, a venticinque anni dalla vittoria sul fascismo e in un celebrato regime costituzionale, dopo una grande somma di lotte e di sacrifici, con la metà dell'elettorato attivo schierato all'estrema sinistra, con una presenza parlamentare numericamente poderosa, con fermenti innovatori e dissacranti all'interno dello schieramento borghese, con un movimento durevole di contestazione e di lotta che in mezza Europa si è mostrato capace di incrinare l'equilibrio del sistema, com'è possibile che la prospettiva più favorevole resti quella del 1946-48? A questa domanda, tanto semplice quanta fondata, non si può rispondere, come si usa, con il richiamo alla dimensione storica dei problemi, alle luci piuttosto che alle ombre, e alla pazienza. Come reagire alla repressione che ad anni alterni si abbatte sul movimento, senza correggere quanto non ha permesso in passato e non permette oggi di tagliarne le radici? Che cosa non è mutato in questi anni nella struttura dello Stato e nella forza delle grandi concentrazioni economiche, che si possa mutare in avvenire senza ricorrere a una nuova e diversa mobilitazione di forze, e a un nuovo progetto sociale che la consenta? Se tutto uri complesso di forze schierate a sinistra — non solo forze operaie ma strati: sociali che hanno un grande peso nella vita economica e culturale del paese e nelle istituzioni — non basta a far fronte a un questore, a un magistrato o a un ministro reazionari, è difficile negare che un limite ben grave della linea generale del partito rivoluzionario ha impedito a quelle forze di conquistare poteri reali, adottare forme di lotta adeguate, prendere coscienza del proprio ruolo, al di là delle scelte elettorali e di una solidarietà esterna con la classe sfruttata. Ed è difficile negare la necessità di una correzione profonda di linea.
Ancora sul problema più scottante, del giudizio sullo stato del partito comunista e della necessità di una rifondazione della sinistra, la nostra radiazione non ha certo confortato chi ancora nutriva una qualche fiducia sui margini di duttilità e di disponibilità vantati nel XII Congresso. Capita di rado di sentir prendere sul serio (se non dall'onorevole Piccoli, che l'ha sottoscritta con invidia) l'accusa di frazionismo, ora che è venuto meno il clima artificioso e il rituale che l'ha accreditata. Facile è la considerazione che un gruppo dirigente che non è in grado di misurarsi con una minoranza dissenziente e neppure di tollerarla non può avere con l'insieme dei militanti, né tanto meno con il movimento esterno e con le molteplici esperienze ed energie che lo percorrono nessun rapporto che non sia povero, pedagogico e interessato. Si può dar credito alle «tavole rotonde», ai convegni di intellettuali, agli ammiccamenti dei dirigenti più « aperti », che ragionano di rinnovamento e continuità, di autonomia e partecipazione di base, quando la pratica delle radiazioni, delle epurazioni, delle emarginazioni invisibili impegna gruppi dirigenti locali contro organizzazioni di base sovrane e contro leali militanti, senza neppure una mascheratura « di principio », ma secondo il calcolo di convenienza e la discriminazione opportunista? Dar credito a un Comitato centrale che ha liquidato la propria opposizione interna?
***
Proprio per questo, perché sentiamo crescere conve genze di giudizio, possibilità di ricerca e di lavoro comune, sollecitazioni al fare, non nascondiamo che accumulano davanti a noi problemi e compiti difficili. Non solo i problemi teorico-pratici di analisi della realtà, di ricerca e costruzione di una nuova strategia senza di cui il movimento operaio d'occidente non farà in un futuro prossimo né lontano la rivoluzione che non ha fatto in questo mezzo secolo; problemi attorno : quali il Manifesto è nato e con i quali potrà adeguatamente misurarsi solo se il concorso di altre energie: consentirà di superare i limiti che qualcuno ci rimprovera, ma dovrebbe fors'anche rimproverare a se stesso, alla propria neutralità o disimpegno. Ma anche i problemi del « che fare » pratico, immediato, de l'azione politica e delle possibili forme di organizz zione, perché il lavoro di ricerca non resti astratto, e il contributo a una riunificazione delle sinistre non resti un'intenzione senza seguito nella realtà.
Un primo interrogativo è di molti compagni tuttora impegnati all'interno del partito in una loro battaglia, che a volte coincide pienamente con la nostra, a volte se ne differenzia su un terreno tuttavia incompatibile con linea dominante e col modo di essere dell'organizz zione. Il proposito di continuare in questa battagla interna si fonda su diverse considerazioni, ma in generale sul fatto che nel PCI si aggrega il massimo delle forze popolari e che qui è il nodo irrisolto della rivoluzione italiana. È così, e per questo abbiamo detto che dividere i compagni tra chi resta e chi rompe sarebbe una riedizione del settarismo che abbiamo combattuto nel partito e in cui non ricadremo. Ma con altrettanta chiarezza credo si debba dire che non può «esservi battaglia interna feconda che non sia fino fondo rigorosa: che si misuri senza, compromessi sulle posizioni politiche; che porti avanti esperienze autonome lasciando ai gruppi dirigenti la responsabilità di rifiutarle; che alimenti quella che abbiamo chiamato e chiamiamo una «rivoluzione culturale»,una crisi dell'organizzazione qual è; che scenda sul terreni dell'aperta solidarietà politica e del lavoro comune con i compagni esclusi dall'organizzazione. L'«entrismo non è, se no, altro che una illusione, che nasce da una sottovalutazione delle proporzioni della crisi che il movimento comunista attraversa su scala interna e interniazionale: di fronte alla quale ogni lavoro sotterraneo in particolare confina con una sostanziale rinuncia.
Un secondo interrogativo è di molti compagni che avendo superato per diretta esperienza o per maturazione di coscienza ogni illusione «entrista» sollecitano ivece un rapido, generalizzato impianto organizzativo, Fondata là dove sono già maturate o maturano, in rapporto a esperienze reali, situazioni insostenibili e possibilità di nuove scelte e aggregazioni, questa esigenza non può essere generalizzata senza riprodurre l'errore e conoscere gli insuccessi dei gruppi minoritari: non solo la sovrapposizione meccanica di una organizzazione al movimento non serve, ma non è neppure possibile, d'un colpo e su vasta scala, se non come riflesso li una rottura internazionale o in presenza di una crisi tumultuosa e di una sconfitta storica del movimento; e perciò approda alla riproduzione di moduli del passato, iella vana speranza che un atto di volontà possa traformare la critica all'organizzazione esistente in una reazione politica. Non per caso alcuni dei gruppi minoritari - anche i più gelosi in una taumaturgica visione «leninista» della « avanguardia » - misurano oggi i limiti di queste impostazióni, la difficoltà di crescere e soprattutto di rispondere.ai problemi di lotta e di schieramento che il processo rivoluzionario in occidente richiede. E molti riflettono su altre strade da battere.
Un terzo interrogativo è di quei compagni, in prevalenza estranei al PCI e alle organizzazioni tradizionali della sinistra, che sfuggono a questi dilemmi considerando la «pratica sociale» come la sola risposta possibile e di per sé esauriente ai problemi di lotta : politici della classe. Quando proviene dal movimento studentesco, questa posizione tende spesso a correggere i troppo ambiziosi progetti del passato e si pone con ragione un rilancio concreto del movimento anche se rimane esposta al rischio della dispersione e a quello della rassegnazione nei confronti delle forze politiche istituzionali. Quando proviene dai gruppi impegnati soprattutto nel lavoro operaio, tende a volte a una esasperazione delle singole esperienze nella convinzione, empirica o dottrinaria, che possano assumere un valore dirompente e supplire a un lavoro politico più generale. E capita che l'indifferenza per le organizzazioni politiche tradizionali si accompagni, paradossalmente, al rifiuto di una lotta politica che ne pronuova la rifondazione.
Quando abbiamo scritto che, oggi, la formazione di una forza politica non può essere che un processo, avevamo presenti questi problemi e questi modi di atteggiarsi di tanti compagni interni e esterni ai pariti della sinistra e ai sindacati. E perciò abbiamo proposto, per cominciare a rispondervi, un lavoro comune, :collettivo, un lavoro di massa che si applichi a ogni ivello della società, e che faccia crescere un'alternativa al sistema come forza politico-sociale, non come disegno intellettuale o atto di volontà o frutto provvidenziale di esperienze separate. Di fronte alle prime verifiche pratiche e alle sollecitazioni che da tante parti ci vengono, due punti credo però debbano diventare più chiari a noi stessi e ad altri: che questo lavoro ha per noi un fine, cioè la riunificazione delle sinistre anticapitalistiche e più precisamente la formazione di una forza politica nuova; e che affidare questo obiettivo a un processo non significa rinviarlo nel tempo senza crearne, giorno per giorno, anche le premesse pratiche e le possibili forme iniziali di aggregazione e organizzazione, quelle che abbiamo indicato ed altre.
Col contributo del Manifesto dove una più larga unità già esiste, ma anche attorno al Manifesto e come una sua specifica espressione: senza assumere questa responsabilità, anche a livello nazionale, non risponderemmo, adeguatamente alla domanda politica che ci viene rivolta. Se il nostro giudizio sulla fase politica che viviamo ci portasse a concludere che non c'è nulla da fare, che è da scontare una sconfitta storica del movimento e una ricostruzione di qui a vent'anni, potremmo muoverci in altro modo. Ma non è questo il quadro che abbiamo di fronte, crediamo in una partita aperta nel breve e nel medio periodo: la formazione di un nucleo politico, che non pretenda alcuna « egemonia » e neppure mutui dalle forze tradizionali il vizio della «centralizzazione», ma assuma comunque una fisionomia precisa, chiarisca le proprie responsabilità dinanzi alle masse, si ponga come un punto di riferimento democratico e perciò sufficientemente definito da poter essere controllato fino in fondo - questo è un compito e uno sforzo al quale non possiamo sottrarci, in coerenza con la scelta che abbiamo compiuto. Anche se è un compito che nessuno può pensare di affrontare senza quel concorso di consensi e di energie molteplici che a noi è apparso, fin dall'inizio, come condizione stessa del nostro operare. La provvisorietà delle risposte che diamo e dell'azione che cerchiamo di sviluppare non riusciremo a superarla da soli, e per fortuna a nessuno diamo unilateralmente, le false sicurezze che le istituzioni consolidate dispensano a piene mani. Un tale superamento potrà avvenire solo se saremo in molti a perdere non solo la vocazione settaria ma anche quella gregaria, e se le sollecitazioni che ci vengono rivolte in proporzioni impreviste si accompagnerà a una comune assunzione di responsabilità politiche e organizzative più generali.
© 2013-2017 FondazioneLuigiPintor
tutti i diritti riservati
CF: 97744730587 – P.IVA: 12351251009

